Una panoramica di racconti e romanzi
su Cuba, è stata realizzata grazie alla collaborazione di
Gordiano Lupi,
uno scrittore tra Cuba e Italia che scrive, traduce e pubblica
interessanti capitoli di storia della vita cubana.
Alejandro Torreguitart Ruiz (L’Avana, 1979) è studente di
letteratura spagnola all’Università dell’Avana, scrive poesie e racconti
per la rivista accademica El Barrio, è poeta repentista e cantautore.
Suona in un gruppo rock chiamato Esperanza. Ha scritto il racconto lungo
La Marina del mio passato che verrà pubblicato in calce al saggio
di Gordiano Lupi Vedere Cuba dalla parte dei cubani (Terzo Millennio
Editore) e il romanzo breve Confessioni di un omosessuale
che uscirà nel 2003 per Stampa Alternativa. Entrambe le opere sono state
tradotte da Gordiano Lupi e sono inedite. Alto materiale inedito è stato
tradotto e attende un editore. Tra questi: Vita da jinetera,
romanzo sul mondo della prostituzione e Bozzetti avaneri, una
raccolta di racconti che non sono racconti come dice lo stesso Alejandro.
Gordiano Lupi è il titolare per lo sfruttamento dei diritti sulle sue
opere sul territorio italiano.
Caro John, mi hanno pubblicato il romanzo...
Sono in Parque
Central, Centro Avana. Tiro a far tardi, come sempre. Però oggi non è un
giorno come tanti. Proprio no.
Caro John, mi hanno
pubblicato il romanzo,
penso.
Ma John non può
capire. È soltanto una statua, lui.
Che poi che cazzo ce
l’avranno messa a fare la statua di John Lennon in Centro Avana me lo
devono spiegare. Era controrivoluzionario ascoltare i Beatles, un po’ di
tempo fa...
Cambia tutto, si vede.
Cambia pure la storia.
E il vecchio John
adesso è qui che si guarda il via vai di Centro Avana. Un buontempone
gli ha rubato gli occhiali poco dopo che lo avevano fissato su questa
panchina di bronzo. Però glieli hanno rifatti quasi subito. Mica come a
mia zia che è miope e non sa come fare, ché le lenti, quelle vere, col
cavolo che si trovano.
Accarezzo la statua di
bronzo e sorrido.
Tu sì che hai
fortuna, John. Tu non senti niente. E ti frega assai dei problemi del
mondo. Ti interessa di molto se mi hanno pubblicato il romanzo. Nemmeno
i piccioni ti danno fastidio. Se li sono mangiati tutti, con la fame che
c’è in giro.
Romanzo pubblicato,
allora.
E adesso? Cosa
cambia?
Cambia niente, cambia.
Sono sempre qui che
giro per la vecchia Avana con il sidecar. Turisti che vanno,
turisti che vengono.
Lezioni rivoluzionarie
su Guillén e Carpentier. Che poi sono bravi, lo so. Vuoi mettere loro
con me. Nemmeno a pensarlo. Però due palle...
Serate con l’Esperanza
a pestare forte sulla batteria.
E poi zitto come una
tomba. Non lo posso neppure dire.
Tu dimmi che
soddisfazione c’è a pubblicare un romanzo e nessuno sa che l’hai fatto.
Un po’ come scoparsi la più bella mulatta dell’Avana e non poterlo dire.
Se ne va metà del gusto.
Juventud Rebelde
in edizione speciale e uno strillone nero di Centro Avana che grida:
Machi di carta, il romanzo confessione d’un giovane avanero. Vuoi
mettere? Tutta un’altra cosa.
E il passa parola,
la gente che ti guarda per strada.
È lui. Però che
coraggio. Che bello il romanzo che ha scritto.
Sarà finocchio
davvero? Ecco questo dubbio qui mi piacerebbe meno. Però lo direbbero.
Sicuro.
A Fidel però li
girerebbero parecchio, credo.
E allora stiamo zitti,
via. Zitti come topi.
Caro vecchio John, mi
hanno pubblicato il romanzo.
Ecco, giusto a te lo
posso dire. E allora te lo dico un altro paio di volte e poi me ne vado.
Seduto su questa panchina di bronzo ricordo canzoni dei Beatles e penso
a quel che è accaduto e a ciò che non capiterà mai. Però, chi può dirlo?
Anche una statua per John Lennon all’Avana, via... chi se la sarebbe
aspettata?
“Hai qualche
dollaro, amico?” mi fa un vecchio che si è avvicinato alla panchina. Lo
guardo meravigliato. Sarà perché sono vestito bene, oggi. Sarà perché
questo è un posto da turisti...
“Soy cubano egual
que tu, amigo!” dico.
I diritti del romanzo
si vedranno tra qualche mese, se va bene.
Il vecchio si
allontana sconsolo. In lontananza il solito panorama di ragazze che
passeggiano e fingono sorrisi, poco distante uomini della polizia
controllano e mantengono l’ordine. Fidel ha chiuso pure le discoteche,
dice il Granma. Vizi da capitalisti. Covi di drogati e puttane.
Adesso la vita è ancora più dura.
E io sono qui che mi
gingillo e penso al romanzo.
In Italia qualcuno lo
starà leggendo, credo.
“Stattene buono e
aspetta” ha detto il camajan.
Che poi il camajan
sarebbe il marito di mia cugina, quello che traduce le cose che scrivo,
credo di averla già detta questa cosa.
“Ci vogliono almeno
sei mesi per sapere com’è andata”.
E io aspetto.
Aspetto il prossimo
tornado, magari. Aspetto che mi dicano ancora una volta che la
rivoluzione va difesa ogni giorno e io sono qui, pronto a difendere il
niente. Aspetto che Juliana torni, prima o poi. Perché ritornano tutte,
questo è sicuro. Aspetto che a Pablo si scordi la chitarra la prossima
volta che gli viene in mente di suonare Manolin per scoparsi una
ragazza.
E aspetto di cantare
Yesterday, caro John.
Sì, c’è poco da
fare.
Non mi resta che
aspettare.

1. Mi presento
Per cominciare dirò
che mi chiamo Maicol, ho ventitré anni e la pelle mulatta, però ho i
capelli neri e lisci come un bianco. Questo ci tengo a precisarlo perché
da noi è importante. Si dice che a Cuba non c’è razzismo, ma non è mica
vero. Persino i neri tra loro dicono scherzando che “in casa mia di nero
basto io…”. Sono abbastanza alto, ho le gambe lunghe e il sedere
stretto, le labbra carnose e il naso piccolino, gli occhi neri e sottili
dal taglio cinese, le mani delicate. Le ragazze si innamorano del mio
sorriso, dicono che dà luce a tutto il viso. Quando vengono a sapere che
sono omosessuale ci restano male. Tutti dicono che la mia bellezza è
femminile, delicata e che ho poco da invidiare a una donna. Quando ballo
mi muovo con eleganza e conosco a memoria i passi della salsa e
del merengue. Da quando sono in Italia insegno danza e mi
esibisco in qualche festa. Vivo a Livorno, una città di mare che ricorda
un po’ L’Avana e mi fa sentire meno la nostalgia. C’è addirittura un
piccolo Malecón nella zona dell’Ardenza, simile al nostro però più basso
e stretto. Nelle giornate di libeccio mi fermo a guardare il mare e il
volo dei gabbiani. Sogno L’Avana. Sogno i bambini schizzati dal
salmastro. Qui non accade, il mare se ne sta buono al di là del muro e
un po’ ci resto deluso, ma comunque è bello stare con il volto proteso
sulle onde a respirare il profumo del mare, specie quando il tempo è
cattivo. Qui non c’è pericolo di cicloni e si può fare. Mi hanno detto
che il libeccio, per quanto violento, non fa mai i danni delle nostre
tempeste. A Livorno d’estate si può andare al mare e d’inverno non è che
il freddo sia così terribile. Si sopporta. Basta un cappotto e fare
l’abitudine ai maglioni di lana. Pizzicano un po’ e fanno arrossare la
pelle, però ci si abitua. Vivo qui con Luca, un avvocato di trent’anni
che ho conosciuto all’Avana. Luca è un bel ragazzo dai capelli castani e
gli occhi verdi, alto, interessante. Mi ha affascinato subito per il suo
modo di fare, così diverso da quello di tanti turisti che vengono a
Cuba. Galante, romantico, sensibile. Mi ha detto che in Italia ha sempre
fatto tutto di nascosto, temeva per la sua professione specie i primi
tempi. Adesso è un avvocato inserito, ha rilevato lo studio del padre e
ha un bel giro di clienti. L’omosessualità non è più un problema. Ecco
l’Italia mi piace per questo: io e Luca possiamo vivere insieme alla
luce del sole e nessuno ci trova niente da dire. Certo i pettegolezzi
dei vicini di casa sono inevitabili, ma all’Avana sarebbe stato peggio.
Luca era venuto a
Cuba in cerca di qualcosa di diverso, aveva letto Garcia Lorca e il
diario dove confessa che soltanto all’Avana si sentiva libero di
esprimere la sua omosessualità. Vedeva Cuba come il paradiso dei gay, un
posto dove era possibile essere se stessi senza problemi. Avevo letto
anch’io Garcia Lorca, che diamine. E avevo letto anche Lezama Lima e
Senel Paz, però mi ero convinto che fosse soltanto letteratura.
Letteratura e leggenda romantica. Forse L’Avana era così per uno
straniero pieno di dollari, per un turista. Non per un cubano che ci
doveva vivere. Perché vivere all’Avana da gay è dura, è sempre stata
dura.
In ogni caso io e
Luca ci siamo innamorati. Avevamo interessi simili, gusti simili, al di
là che mi piaceva molto e io piacevo a lui. Perché il sesso è
importante, se manca l’attrazione fisica manca quasi tutto, ma non è che
si viva soltanto di sesso.
Luca è un avvocato un
po’ particolare, non si occupa solo di codici e leggi, quando stacca
dallo studio pensa ad altro. Legge molto, ama la poesia, la letteratura
cubana, conosce un sacco di cose che a me sono sempre piaciute. Stiamo
bene insieme anche per questo.
E’ stato lui a
spingermi a scrivere questa storia della mia vita.
“Ti servirà a
guardarti dentro. Scrivere è una liberazione” mi ha detto. Lo fa spesso
anche lui di buttar giù dei pensieri, delle brevi poesie, me ne ha
scritte di stupende quando eravamo a Cuba e qualche volta me ne scrive
ancora.
Luca ha fatto di
tutto per farmi venire in Italia. Non è stato facile, però. Da Cuba si
esce soltanto sposando uno straniero e tra due uomini non era proprio
possibile. Da quando sono qui leggo e ascolto cose che mi sconvolgono. I
gay chiedono la legittimazione delle coppie e in qualche paese del nord
Europa già succede. Forse un giorno potremo averlo anche noi. Mi sembra
un sogno.
Luca è stato davvero
grande. Ha portato all’Avana una sua amica omosessuale e mi ha fatto
sposare con lei. E’ stato divertente. Un matrimonio in piena regola
celebrato a La Maison con firma sui registri e auto d’epoca. Lui
ha fatto da testimone e da traduttore ma per noi è stato come sposarci
davvero. Paola era soltanto un mezzo per raggiungere lo scopo e alla
fine della cerimonia formale ha lasciato il posto a Luca ben volentieri.
Abbiamo fatto un giro in auto sul Malecón per scattare qualche foto al
tramonto e subito dopo una festa a Regla in casa della nonna, dove
abbiamo bevuto e ballato fino al mattino.
Ho dovuto attendere
un paio di mesi per ottenere il visto per l’espatrio, ma poi è arrivato.
Non potevano rifiutarlo: ero sposato.
Sono arrivato in
Italia a gennaio e non posso negare che un po’ la differenza l’ho
sentita. Freddo polare, pungente. Vento di tramontana e libeccio. Io ero
uscito da Cuba soltanto una volta con il gruppo di ballo, però era
agosto quando partimmo per una turnè in Spagna e non avevo sentito una
gran differenza. In vita mia non avevo mai indossato niente più che una
maglietta di cotone e un paio di pantaloni leggeri. In Italia non era
proprio la stessa cosa. E poi mi mancava la musica e il chiasso della
mia gente. Uno stereo acceso giorno e notte a tamburellare ritmi di
merengue e salsa. Il silenzio è la cosa che ancora fatico ad
accettare, soprattutto d’inverno. Perché quando viene l’estate non è che
gli italiani siano così diversi dai cubani, con la bella stagione escono
fuori dal guscio e sanno divertirsi. E’ anche un problema di clima, in
fondo.
Mi mancano anche le
vicine di casa che irrompono senza bussare con la scusa di farsi
prestare un po’ di zucchero o del caffè e poi si fermano per ore a
spettegolare e a commentare le ultime puntate della novela
trasmesse dalla televisione.
Qui ognuno vive a
casa propria.
Io mi sforzo di
riprodurre un’atmosfera cubana, almeno in casa mia. Però non è facile.
Per esempio lo stereo va tenuto a basso volume perché dà fastidio ai
vicini. I lati negativi sono tanti, è vero. Però anche le cose buone non
vanno dimenticate. Qui vivo tranquillo con Luca e poi ho un lavoro,
insegno danza latino-americana in una palestra e guadagno dei soldi. Ho
una casa vera e una solidità economica, senza dovermi ingegnare ogni
giorno a procurarmi pranzo e cena. Non tornerei indietro, certo che no.
Anche se Cuba mi manca, perché negarlo? E’ la mia terra. E mi capita
spesso di sentire che in fondo al cuore è ancora aperta una ferita di
nostalgia...
il libro, edito da StampAlternativa, si
trova già in libreria
Poesia a ritmo di
salsa
Carrellata di
giovani poeti cubani
Prima puntata
di Gordiano Lupi
La poesia cubana prodotta dalla Rivoluzione Castrista non può
prescindere dall’ideologia e dalla storia e si inserisce in un contesto
dove “l’arte è un’arma della Rivoluzione”. Sono parole di Fidel Castro
che si è sempre rivolto agli intellettuali ammonendoli a restare dentro
la rivoluzione, perché al suo interno sarebbe stata permessa ogni
libertà (con i dovuti limiti). E’ ovvio che la “poesia delle due
sponde”, la poesia cubana in esilio, ha caratteristiche diverse,
generalmente di protesta e polemica nei confronti del regime comunista.
Nell’economia di questo scritto ci occuperemo soltanto della poesia che
si scrive sull’isola (anche se spesso viene pubblicata soltanto
all’estero per svariati problemi, non ultimi quelli di natura
economica).
Dopo il 1959 la poesia si storicizza e si cala nella realtà, rifuggendo
da visoni surreali e mitiche. La poesia collabora alla costruzione
dell’uomo comunista ed è al servizio della nuova idea che, almeno
durante i primi vent’anni, è capace di infiammare gli animi.
Non si può parlare di poesia cubana moderna senza prima fare un breve
accenno ai due grandi nomi che hanno caratterizzato la letteratura
dell’isola negli ultimi due secoli:
Josè Martì
(1853 – 1895) e
Josè Lezama Lima
(1910 – 1976).
Josè Martì è considerato l’eroe dell’indipendenza, morì combattendo
contro i colonizzatori spagnoli e fu poeta di radice whitmaniana,
anticipatore della poetica modernista (di lui si ricordano soprattutto i
Versos Sencillos del 1891, che contengono anche le parole della
celebre canzone Guantanamera). Non fu solo poeta, ma anche
narratore per l’infanzia (fondò la celebre rivista La Edad de Oro),
saggista, uomo politico e romanziere. Tutta l’educazione della gioventù
cubana passa attraverso l’insegnamento capillare della sua opera.
Lezama Lima ebbe molti discepoli che si radunarono attorno a lui e alla
sua rivista Origines, fu autore di poesie ermetiche e visionarie
(Muerte de Narciso, 1937) e del grande romanzo filosofico di
matrice proustiana Paradiso (1966) seguito dall’incompiuto
Oppiano Licario (postumo, 1977). La poesia moderna deve molto a
Lezama Lima e alla rivista Origines che produsse l’antologia
Diez poetas cubanos (1948).
La prima poesia post rivoluzionaria la troviamo nell’antologia Poesia
Joven de Cuba (1959) ed è un qualcosa di molto moderno. “La poesia -
dicono gli stessi autori nell’introduzione - penetra la vita quotidiana
e si nutre di essa, nutrendola a sua volta. Deve essere ricca di prosa e
dialoghi, ma anche di violenza, effusioni sentimentali, preoccupazioni
sociali e politiche, sgorbiature, impurezze”. Queste parole sono un
manifesto che rompe con la tradizione romantica e inserisce il ruolo del
poeta come fondamentale all’interno di una nuova società da costruire.
Altra rivista importante è El Caiman barbudo (fondata nel 1966)
che accentua la poetica conversazionista e colloquiale portandola alle
estreme conseguenze, sino a svilirla e farla morire. El Caiman ha
la sventura di nascere in un periodo molto buio per la cultura cubana,
il cosiddetto quinquennio grigio, quando il poeta è quasi
totalmente asservito alle esigenze della Rivoluzione. Eccessi di
retorica e di nazionalismo caratterizzano il gruppo del Caimano, che non
fu neppure in grado di darsi una propria antologia, ma soltanto un
manifesto intitolato Nos pronunciamos.
I poeti degli anni settanta, in polemica con questa retorica di regime
troppo spinta, impostano una visione anti colloquiale della poesia.
Questi autori vogliono liberare i versi dalle trappole dei troppi
elementi prosaici e dagli eccessi colloquiali, però finiscono per cadere
nell’eccesso opposto. Ne viene fuori una poesia stucchevole che non ha
più alcun legame con la realtà e rifugge dalle radici sociali. E’ il
tojosismo (da tojosa la colomba selvatica delle campagne
cubane), una corrente che si rivolge verso il mondo rurale e vuole
riaffermare i valori nazionali e le bellezze dell’isola. Si recuperano
forme strofiche in disuso come il sonetto e la decima. Un
esempio lo troviamo nell’antologia Nuevos Poetas curata da
Roberto Diaz. Dopo questa caduta verticale, negli anni successivi si
assiste a una graduale ripresa di consistenza del discorso lirico. I
poeti degli anni ottanta propongono un nuovo modo di storicizzare la
poesia, pur senza tornare agli estremi del colloquialismo. Gli anni
novanta si esprimono nell’antologia Cuba: en su lugar la
poesia (1982) Fu un periodo di fioritura poetica senza precedenti
capitanato da Raul Hernandez Novas. Infine i nuovissimi autori degli
anni novanta, che sono quelli che ci interessano più da vicino,
riscoprono la trova e la lirica cubana (il Guillermo Tell
di Carlos Varela ne è l’esempio più significativo) e attraverso quella
radicalizzano i conflitti generazionali. Si torna allo squilibrio e allo
sconcerto, cambia la visione del mondo. Il poeta vive ai margini della
società e non al suo interno, cerca il rischio e ama l’avventura,
disprezza le regole dei padri. La poesia vive a stretto contatto con la
musica, tanto è vero che molti poeti sono anche cantautori (Frank
Delgado), cantanti rock (Carlos Varela) o improvvisatori di strofe
cantate o repentistas (Alexis Diaz Pimienta). La poesia cubana di
fine secolo è lacerata e luminosa ed è lo specchio di una situazione
sociale difficile e precaria. I poeti contemporanei mettono sulla
carta tutte le incertezze e contraddizioni di una società che cambia e
non sa dove è diretta. Una società che a parole si dice ancora
comunista mentre nei fatti si apre a forme di capitalismo imperfetto che
acuiscono le differenze sociali e gettano la popolazione nello
sconcerto.
Il poeta si fa interprete di queste esigenze e offre il suo canto
all’analisi di un quotidiano difficile da capire.
Vogliamo cominciare questo nostro viaggio all’interno della poesia
cubana degli ultimi anni novanta presentandovi una lirica di Alexis Diaz
Pimienta.
Le lettere smarrite
Per favore, non recuperate le lettere smarrite.
Lasciate la busta accanto al tronco dell’albero,
sotto un’anonima pietra, o a rotolare nei giardini.
Ci sono lettere che si scrivono perché non arrivino,
perché dall’altro lato della voce diffidino di tutto,
perché esista una seconda lettera, esplicita e inutile.
Ciò accade con l’assenso di tutti,
con soprassalti premeditati e complicità.
Sono mesi, anni, di matematica innocenza.
In quelle lettere si confessava tutto,
si annunciavano pericoli che poi la pioggia ha ammorbidito;
in quelle lettere c’erano poscritti che premonivano
sul fatto che sarebbero andate smarrite.
La loro vera destinazione era il silenzio,
le erbacce al bordo dei letti,
le ragnatele sui davanzali,
le nuvole sul volto.
Definitivamente,
dall’altro lato della voce non l’aspettavano.
Lasciatela accanto all’albero,
sotto un’anonima pietra,
a rotolare nella memoria del felice mittente.
(traduzione dallo spagnolo di Danilo Manera – da L’isola che canta
giovani poeti cubani – Feltrinelli, 1998)
Alexis Diaz Pimienta
(L’Avana, 1966) è un poeta repentista e lavora al Centro
Provinciale della Musica dell’Avana. Ha pubblicato all’estero
(soprattutto alle Isole Canarie) molte raccolte di poesie (Cuarto de
Mala Musica 1995, En Almeria casi nunca llueve 1996,
La sexta cara del dado 1997, Pasajero de transito
1997, Las palmas de Gran Canaria 1997). Ha pubblicato una
raccolta di racconti, Los visitantes del sabado, 1994.
In Italia si possono leggere sue poesie nel volume L’isola che canta,
Feltrinelli 1997 e racconti in La baia delle gocce notturne, Besa
1996 e Vedi Cuba e poi muori, Feltrinelli, 1997.
I
due primi capitoli di POESIA A PASSO DI SALSA, lezioni di letteratura
cubana.sono
state pubblicate da IL FILO di Roma (ottobre - novembre).
|
 IL GIUSTIZIERE DEL MALECON
IL GIUSTIZIERE DEL MALECON |
|
Un letto disfatto e pareti bianche, fuori il sole di
sempre.
E’ normale lasciarsi andare ai pensieri da un
letto d’ospedale. Ripercorrere il passato, quello che è stato e
soprattutto ciò che avrei potuto evitare. Andare con la mente in un
viaggio a ritroso nel tempo e accarezzare emozioni lontane.
Soprattutto perché adesso sono sola e intorno vedo solo medici e
infermieri. Non che mi manchi qualcosa. Tutti sono così gentili e
ascoltano ogni richiesta per compiacermi. Però devo guarire in
fretta e tornare quella d’un tempo, mio figlio Danilo mi attende e
non può stare solo con la nonna, a Toyo. Devo portarlo nella nostra
casa di Luyanó. Ho soltanto lui per compagno, da quando quell’italiano,
che per un gioco del destino è stato suo padre, mi ha abbandonato.
Volevo essere io a decidere sul futuro e ho scelto di vivere le luci
della notte, che si specchiano sul Malecón e fanno compagnia alla
luna nei riflessi di acque torbide e nere. Ho scelto le discoteche
per turisti, i grandi e lussuosi hotel davanti a case di povera
gente. Questo è il mio mondo. Cavallerizza della vita. E mi chiamano
con disprezzo jinetera. Le comari del quartiere mi guardano
storto quando vesto gli abiti della notte e fuggo via da un
polveroso quotidiano. Attraverso la calzada delle quatros
esquinas, poi prendo un taxi in direzione della vita, indossando
scarpe altissime e gonne corte dai colori sgargianti.
Che altro posso fare? Ho solo un corpo da
vendere e lo faccio fruttare bene. E’ l’unico modo che conosco per
dar da mangiare a un bambino di quattro anni che non ha mai
conosciuto suo padre. La mia unica vendetta è quella di vivere alle
spalle di gente come lui. Sono sempre io ad abbandonarli. Sono io
che decido quando è il momento di farla finita. Non mi innamoro mai.
Non mi innamoro più, da tempo. I sogni non attraversano le strade di
queste notti disperate condite d’avventura. Notti di sesso e strade
scolpite da vento caldo in ogni stagione. Balli e sudore sotto le
stelle.
Mi chiamo Maria, ho venticinque anni e vivo sola
a Luyanó. Mia madre abita a Toyo e la vedo quasi ogni giorno,
soprattutto per lasciarle Danilo. E’ un bambino e non lo voglio
immischiare nella mia vita, in questi squallidi incontri dove il
sorriso è obbligato e l’amore soltanto finzione. Così lui sta spesso
con la nonna, in un palazzo davanti a un negozio di pane e dolciumi,
sopra un bel porticato stile coloniale screpolato da vento e
incuria. Là trova una famiglia normale e tanta gente che lo fa
giocare. Ci sono i miei zii e le cugine, un appartamento di tre
stanze accoglie almeno tre famiglie e c’è sempre allegria e rumore a
ogni ora del giorno. Danilo va volentieri dalla nonna. Sa che là può
giocare a nascondino per le scale del palazzo o farsi rincorrere in
strada, dove non passano che poche auto su di un fondo sconnesso.
Ci sono ragazzi più grandi che a volte rimediano
una pelota e lui cerca di inserirsi nel gioco in tutti i
modi. E’ sveglio Danilo e non si stanca mai. Mia madre è ancora
giovane e sa come domarlo, forse più di quanto non riesca a fare io
che devo farmi perdonare troppe cose. Stiamo così poco insieme che
quando capita voglio solo assaporare il suo respiro lieve vicino al
mio petto e questo basta per rendermi felice. Tutto quello che
faccio è per lui. L’unico uomo della mia vita.
Mia madre dice che sono una bella ragazza e che
gli uomini si innamorano di me soltanto a guardarmi passare. Credo
che in parte sia vero, perché quando voglio trovare compagnia per la
notte non fatico molto. E riesco anche a scegliere e a scoraggiare
chi non mi va a genio. Dicono che siano i miei occhi neri e il
sorriso ad attrarre, ma anche i lunghi capelli dello stesso colore
che mi scendono liberi dietro le spalle. Sono abbastanza alta e
indosso gonne cortissime dai colori vivaci che fanno risaltare le
lunghe gambe. Gli uomini mi mangiano con lo sguardo e poi qui la
gente non te lo manda a dire quando ti trova carina. Lanciano
piropos scherzosi e volgari che ti fanno arrossire e io rispondo
con un sorriso a tutti, tanto se non pagano se lo possono togliere
dalla testa che mi sprechi per loro. E un cubano non lo voglio
neppure per regalo. Ubriaconi e perdigiorno, non sanno fare altro.
Vivono tra caffetteria e feste, corrono dietro alla prima gonna che
scopre le gambe un poco sopra il ginocchio, tradiscono con
leggerezza. E poi la donna per loro è poco più che un oggetto.
Non che gli stranieri siano migliori ma almeno
hanno i dollari in mano. Il cubano vive di espedienti, piccole
truffe ai danni dello stato, affari con turisti. E lo stato se lo
merita in fondo, perché la paga mensile per un lavoro normale non
supera i duecento pesos. Dieci dollari. E’ fondamentale arrangiarsi
e inventare qualcosa se si vuole mangiare. La mia fortuna è quella
di possedere un bel corpo. La mia unica ricchezza. Un corpo che mi
ha sempre aiutato a vivere e a superare momenti duri. Mi ha fatto
anche illudere quando è stato di quell’italiano che mi ha lasciato
un figlio. A volte lo rivedo specchiandomi negli occhi neri del mio
bambino. Il suo nome era Franco e pareva sincero. Non l’ho più visto
dopo le tante promesse gettate al vento e lui non ha mai conosciuto
il bambino. Doveva portarmi via, lontano. Dovevo andare a vivere con
lui. E invece siamo rimasti soli, io e Danilo. Lo stringo forte al
petto e gli sussurro che per lui sarà diverso, di sicuro. La vita
cambierà e riusciremo a costruire un avvenire o almeno spero, se no
che senso avrebbe tutto ciò?
La politica non mi ha mai interessato. Le
chiacchiere di Radio Reloj e della Cubavision sono
acqua che corre tra canzoni di Manolin e Marc Anthony, tra una
novela e un film. Niente di più. Alle sei della sera, quando
Fidel parla, di solito ho altro da fare e non m’incantano le pause
che confeziona ad arte tra parole studiate e convincenti. Non mi
appassionano le storie assurde che servono solo a far propaganda.
Quando è successo di Elian se ne parlava da mattina a sera, quasi
fosse l’unico nostro problema, come se i veri problemi non fossero
altri. Ci hanno tolto anche la dignità e il rispetto di noi stessi,
possono portarci via anche un bambino.
E adesso sono in quest’ospedale e dalla finestra
una strada imbiancata di polvere accoglie ragazzini in corsa, tra
carcasse d’auto e palme che si lanciano a disegnare contorni di
cielo.
Sola con i ricordi. Piena di rimorsi e
rimpianti.
Tutto sarebbe potuto andare diversamente.
Io non sarei in una stanza del Mazorra a
osservare un angusto ritaglio di cielo. Tanta gente sarebbe ancora
viva, avrei un’amica accanto. Ma non si può cambiare il passato e
allora non resta che ricordare. Ricordare e rimpiangere.
|
|
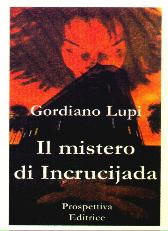 IL MISTERO DI INCRUCIJADA
IL MISTERO DI INCRUCIJADA |
Ricordi di storie
lontane
La vecchia sedia di legno dondola ancora in
faccia al tramonto, nonostante il tempo che è trascorso, nonostante
gli anni.
L’estate comincia a farsi sentire nella quiete
di questa campagna e come ogni giorno, quando il sole scende
silenzioso al limitare dei campi di canna da zucchero, il mio
sguardo si perde tra palme lontanissime e rumori di vento.
Qui sedeva mio nonno, con il sigaro tra le
labbra e la bottiglia di rum nella mano. Ricordo come fosse adesso
quando mi raccontava la storia della casa sperduta ai margini del
bosco, dove cantano le prime civette che aprono le porte alla notte.
Era la casa delle vecchie fiabe e di lontane
paure.
Attendevo l’odore del suo sigaro e le parole,
in compagnia del vento della sera, mentre mia sorella Maria poco
lontano giocava con le bambole di pezza.
Mi sedevo comoda davanti a lui e chiedevo:
“Dai, nonno, raccontami una storia”.
“Quale storia?” faceva lui.
Ma sapeva che era sempre quella che volevo.
La storia della casa maledetta.
La storia della strega che viveva a Incrucijada,
vicino a Cavagna.
Lui diceva di averla conosciuta e che i suoi
lunghi capelli neri scendevano a boccoli su di un sorriso
misterioso.
Mio nonno parlava con voce lieve, soppesando le
parole.
La campagna portava i rumori della notte. Voci
di civette e canti di grilli, vento che muoveva le fronde di
altissime palme e basse mangrovie. Il fiume scorreva vicino e
rumoreggiava acquitrinosi lamenti su gracidare di rane.
Ero piccola allora.
Avevo appena cinque anni ed ero venuta ad
abitare a Cavagna da poco. Mio padre era morto e per noi il futuro
diventava improvvisamente difficile. Una lunga malattia ce lo aveva
portato via e senza di lui non potevamo continuare a vivere in
città. Mia madre non aveva un lavoro e doveva occuparsi di me e di
Maria.
Fu così che accettammo l’invito del nonno.
Trasferimmo le nostre poche cose da L’Avana a Cavagna e cambiammo
vita radicalmente. Non più i viali polverosi e i rumori del porto
industriale che si udivano distintamente dalla nostra casa sulla via
Blanca, ma gli enormi silenzi della notte.
Poca gente intorno. Poca vita.
Case di legno sparse accanto a palme isolate e
distese di canna e banani. Campi di mais e boniato. Frutteti
di mango e guayaba, che lasciavano il posto a dolcissimi
mamey.
Io ero
abituata ai rumori delle strade avanere, allo scoppiettare dei
motori di carcasse di auto cadenti, ai bambini, che facevano girare
una pallina da baseball agli angoli dei vicoli. Non è stato facile
adattarsi a questa immensa campagna lontana dal mare.
Iniziai a passare le sere accanto a mio nonno.
Era un modo per abituarsi a questa nuova vita
fatta di silenzi.
Lui era bravissimo a interrompere le mie
nostalgie e a riempirmi la testa di storie impossibili. Narrava di
fate e folletti. Raccontava avventure di bambini che correvano
liberi nei boschi e incontravano divinità scese sulla terra.
Descriveva con pazienza episodi di una guerra lontana combattuta sui
monti. Episodi che io credevo inventati ma che poi riconobbi come
storie di vita.
Mio nonno era stato sulla Sierra e aveva
lottato per la rivoluzione. Pochi giorni prima di morire mi disse
che tutto quello che gli restava di quel periodo lo aveva raccontato
a me, sotto forma di storia. Niente di più, perché le illusioni le
aveva perdute e le persone in cui credeva erano morte troppo presto.
Mi piacevano quelle narrazioni intense e
appassionate e la mia mente di bambina fantasticava di soldati in
mezzo a trincee improvvisate, che dormivano nel fango. Mi sembrava
di vederli i fucili dei rivoluzionari che calavano su di un nemico
organizzato, dopo averlo attirato in imboscate incredibili tra le
montagne. Lui però sapeva benissimo qual era il racconto che
preferivo e lo teneva in serbo per ultimo, come una meta da
raggiungere e un premio da meritare. Io attendevo paziente la storia
che mi incuteva maggior terrore.
La campagna, con il suo silenzio e i lugubri
canti di uccelli notturni, accompagnati dal gracidare delle rane dai
fossi e dai grilli nei prati, cominciava a farmi paura dopo il
tramonto.
Non contenta chiedevo a mio nonno di completare
l’opera, parlandomi della casa lontana con il tetto di fronde di
palma.
Era il mio incubo. Spesso la sognavo.
A volte immaginavo il volto affascinante e
malvagio della strega. Mio nonno diceva che era bella da impazzire e
che da giovane aveva fatto perdere la testa a molti ragazzi del
villaggio. Però non si era mai sposata con nessuno e chi era stato
visto con lei dopo poco tempo aveva fatto una brutta fine.
Raccontava mio nonno che il suo primo pretendente era stato il
medico di Cavagna, un bel ragazzo di carnagione scura, corporatura
massiccia e lineamenti decisi. Lo videro uscire con lei per qualche
settimana, suscitando l’invidia di tutti i giovani del paese, perché
Isabel era davvero bella. Poi improvvisamente si ammalò. Rimase
bloccato nel letto per mesi e nessuno scoprì l’origine di quella
strana malattia. Morì tra atroci sofferenze dopo un anno, quasi
implorando che la vita gli venisse tolta.
Isabel era scomparsa nel nulla.
Era tornata a rifugiarsi nella sua casa ai
margini del bosco e non aveva frequentato più nessuno per molto
tempo.
Un paio di anni dopo la rividero con un
proprietario terriero di nome Roberto, che possedeva la gran parte
dei campi di canna di Cavagna. Un uomo importante, che dava lavoro a
tanti braccianti e pagava regolarmente i suoi conti. Era stimato da
tutti e si sapeva far ben volere anche dai suoi lavoranti. Non era
un atteggiamento comune tra i padroni, solitamente inclini a
sfruttare i contadini e a non curarsi delle condizioni dei poveri.
Mio nonno mi diceva che se i proprietari
fossero stati tutti come lui non ci sarebbe stata nessuna
rivoluzione.
Isabel usciva con il suo uomo e passeggiava per
le vie del corso principale di Cavagna nei giorni di festa.
A messa la domenica, però, non ce la videro
mai.
Era l’unica donna di tutta la campagna che non
andasse mai a una funzione religiosa e non praticava neppure i riti
santeri della tradizione.
La relazione con Roberto durò tre settimane,
perché un giorno lui venne trovato morto nel bel mezzo di uno dei
suoi tanti campi di canna. Fu una morte orribile. Il suo corpo era
diventato gonfio e nero e in bocca gli avevano piantato a forza tre
canne da zucchero divelte.
Mio nonno assicurava che non poteva essere
stato nessuno dei suoi operai perché tutti lo amavano e lo
rispettavano.
Era stata la bruja a punirlo. E lo aveva
fatto nel modo peggiore.
Isabel rimaneva sempre sola e nessuno aveva più
il coraggio di avvicinarla. Poi fu lei stessa a isolarsi sempre più.
Non voleva uomini intorno e non cercava marito perché ce l’aveva
già, diceva mio nonno. Era sposata con Satana.
Adesso che sono un poco più grande e che il
nonno non c’è più, penso che probabilmente parlava da innamorato
respinto.
Probabilmente Isabel piaceva anche a lui e ci
aveva provato a lungo, senza successo. Le strane storie su di lei le
aveva sicuramente inventate alla caffetteria mentre trangugiava la
sua quotidiana mezza bottiglia di rum con gli amici.
Ho quindici anni e non posso continuare a
credere nelle streghe e nei patti satanici. I suoi racconti però
sono un ricordo di fanciullezza che vorrei riuscire a esplorare. Un
mondo misterioso che attende soltanto di essere scoperto e
conquistato.
E’ per questo che ho deciso di levarmela questa
curiosità.
Tra poco ci andrò a quella casa lontana,
insieme a Maria e Luis, il nostro miglior amico, che ha un paio di
anni di più e gli stessi ricordi d’infanzia. Siamo convinti che
siano tutte leggende.
Racconti del popolo e nulla di più.
Per questo vogliamo andare a vedere. Per
smettere di avere paura quando cala la notte e lo sguardo corre
lontano.
Io ricordo spesso mio nonno e il suo sigaro
acceso a rischiarare il buio. Rammento le storie e le sue mani
scarne. Il bene che mi voleva e la gioia che provavo nello stare a
sentire parole nel caldo di quelle sere d’estate. Tornano a mente le
paure dell’infanzia e i racconti che non riesco a scordare.La solita
vecchia storia di Incrucijada. E adesso mio nonno non c’è più per
stringermi forte al petto e darmi il bacio della buona notte. Le mie
paure devo affrontarle da sola.
|
|
Il primo capitolo di Vita
da Jinetera
di Alejandro Torreguitart Ruiz
Completamente inedito
Alejandro
Torreguitart Ruiz
(L’Avana, 1979) studente di letteratura spagnola all’Università
dell’Avana, scrive poesie e racconti per la rivista accademica
Esperanza, è poeta repentista e cantautore. Non ha
pubblicato niente in patria. Suona in un gruppo rock chiamato El
Barrio. Di lui per il momento Gordiano Lupi ha tradotto il
racconto La Marina del mio passato che dovrebbe andare a
formare il capitolo conclusivo del saggio VEDERE CUBA DALLA PARTE
DEI CUBANI (Terzo Millennio Editore) e il romanzo Le confessioni
di un omosessuale che uscirà nel corso del 2003 nella
collana Eretica di Stampa Alternativa.
Adesso Lupi sta
traducendo il romanzo Vita da Jinetera, un vero e proprio
viaggio nella prostituzione per turisti e alcuni racconti di taglio
esistenziale (Vento tropicale, Una mattina con la testa tra le mani,
Donna di fuoco...).
Alejandro è un autore dallo stile indefinibile,
grande ammiratore di Pedro Juan Gutierrez e di Lezama Lima, fa suo
il realismo magico sudamericano e lo metabolizza in una spietata
analisi del quotidiano. |
|
Coral negro de
L’Avana/ tremendisima mulata…
La radio diffonde
una musica che rimbalza nelle mie orecchie. Un vecchio motivo che
nessuno canta più da anni. Piaceva a mia nonna, credo. Lo hanno
riportato gli europei e le loro stupide mode.
La flaca.
Por un beso de
la flca/ jo daria lo que fuera…
Che puttanate ci
tocca ascoltare…
Anche per oggi è
finta, comunque. Si torna a casa, se Dio vuole.
E anche se Dio non
vuole, nella mia vita Dio c’è sempre entrato poco.
Mi tolgo di dosso
le braccia pelose dell’uomo che ho rimorchiato ieri e mi alzo dal
letto. Sono in un appartamento di Nueva Vedado, poco lontano da
calle venticinco, la lunga direttrice che conduce al Malecón. Mi
vesto con calma, quindi passo in bagno per sciacquarmi la faccia e
rifarmi il trucco. Lui dorme. Russa, addirittura. Non si accorgerà
neppure che me ne sono andata. Qui non ho più niente da fare.
Stringo i cento dollari tra le mani ed esco. Troverà un’altra per
domani. Ce ne sono tante. Non voglio neppure salutarlo e sentire
quell’odioso accento tedesco. Esco dalla camera accostando la porta
con delicatezza, attraverso l’ingresso e la cucina, qui incrocio lo
sguardo della padrona di casa. Lei non saluta, mi osserva di
sfuggita e continua a fare le sue cose. So cosa pensa ma non mi
interessa.
“Che il diavolo ti
porti, vecchia megera” mormoro. Non può sentirmi.
Mi allontano verso
calle venticinco dove ferma la guagua. Sento bruciare
sulla pelle il sole del mattino. Un sole che è sempre lo stesso,
estate o inverno. Si torna a casa, penso. Intorno a me la
vita di sempre. Gente che passa, bambini che corrono, cani randagi
che mendicano un pezzo di pane. Qualcuno che fischia alle spalle. Un
nero sorride da un’auto scassata. Un lavorante della microbrigada
si sporge dal balcone di un palazzo in costruzione e mi lancia un
bacio.
“Vieni qui,
mulatta!” grida.
Rispondo con un
sorriso.
Sono così gli
uomini all’Avana. E forse anche nel resto di Cuba. Se passa una
bella ragazza non possono fare a meno di lanciarle un complimento.
Fa parte del loro modo di essere e a noi piace, in fondo. Ci
sentiamo desiderate, abbiamo la sicurezza d’essere attraenti. Io ho
venticinque anni e mi sento vecchia di fronte alle ragazzine che
fanno la vita. Ho un figlio di otto anni, una casa dove tornare, una
famiglia.
“Vengo a pranzo da
te, mulatta. Se cucini come cammini mi mangio fino all’ultimo
cucchiaio di riso!” grida un nero che si è fermato sull’altro
marciapiede soltanto per osservare il movimento ondulatorio delle
mie natiche.
“Non so cucinare”
rispondo sorridendo.
“Vengo lo stesso.
Tanto sono a dieta…”
Non restano
indietro questi uomini,
penso.
“Lascia stare che
è meglio” concludo.
Succede sempre
così. Gli uomini mi mangiano con gli occhi quando passo per strada.
Ci provano. Mi fanno complimenti. Io lascio fare. Sorrido.
Ringrazio. Tanto alla resa dei conti sono io che decido e il fatto
che abbiano dollari è l’unica cosa che conta. Ieri sono andata a
letto con quel bestione tedesco che puzzava come un animale. Era
sudato e pieno di birra, alito e ascelle mandavano un odore
pestilenziale, eppure ci ho passato la notte concedendo il minimo
indispensabile. Questi europei non sono dei grandi amatori, si
stancano quasi subito. Due pompate e via. Tutto finito. Se sono
vecchi è anche meglio. Durano meno e il guadagno è più facile.
Adesso ho cento
dollari in tasca e meno pensieri.
Raggiungo il
terminal della guagua, proprio di fronte al vecchio
giardino zoologico. Ci ho portato Daglis un po’ di tempo fa e
ricordo ancora la sua felicità davanti alla gabbia dei leoni e a
quella dei gorilla. Non se ne sarebbe mai andato.
“Aspetta la
guagua?” chiede una signora di mezza età che usa un ombrello
rattoppato per trovare riparo dai raggi del sole.
“Sì, quella che va
a Luyanó” rispondo.
“Ha tre ore di
ritardo. Si è rotta e la stanno riparando”.
Bene, come in
Lista di attesa. Solo che qui non è un film.
Penso.
Decido di prendere
il taxi, tanto ho cento dollari in tasca e posso permettermelo. C’è
Daglis che mi aspetta e non posso tardare.
Siamo tornati a
vivere a Luyanó da un paio d’anni, proprio nella vecchia casa di
quando era vivo il babbo e io e mia sorella Manuele sorella soltanto
due bambine. L’ho ricomprata con i soldi guadagnati facendo la vita.
E’ stata una bella soddisfazione.
“Sei tu, Juliana?”
domanda mia madre dalla sala.
“Sì, mamma. E’
rientrato Daglis?”.
“E’ qui con me.
Stiamo facendo i compiti”.
Daglis appena
sente la mia voce scende dalla sedia e mi viene incontro.
“Mi hanno dato da
imparare a memoria una poesia di Martí. Non ci riesco”.
“Vediamo un po’”
dico io “prova a ripeterla…”
“Cultivo una
rosa blanca/ en julio como en enero/ para el amigo sincero/ que me
da su mano franca…”
“E poi?”
“E’ qui che è
difficile. Non ricordo la seconda parte”.
“Leggila ancora”.
“Perché si devono
studiare le poesie a memoria? A cosa serve?”.
“Quella poesia è
molto bella, Daglis. Devi impararla”.
Non voglio che mio
figlio diventi come me. Lui deve studiare, imparare tante cose,
apprezzare le poesie, l’arte, i libri. Lui deve fare una vita
diversa. Ne ha le possibilità. E poi qualcosa cambierà in questo
paese, prima o poi. Vedo che fa una smorfia, poi si rimette a
sedere. La nonna continua a leggere la seconda parte della poesia.
La imparerà, ne sono sicura. Daglis è un ragazzo sveglio e
intelligente. Un po’ vagabondo, magari. Ma quando vuole le cose le
apprende.
“Ha telefonato tua
sorella” dice mia madre.
Io sono sdraiata
sul divano per riposare.
“Cosa ha detto?”.
“Viene a cena da
noi con il marito”.
“Con quel nero
parassita?”.
“Non parlare così
di tuo cognato. Non mi piace”.
“Proprio un nero
si doveva andare a prendere per marito... Un nero senza un quattrino
che sta con lei solo perché io provvedo per tutti…”.
“Non essere troppo
dura con lui”.
“E’ stata Manuela
a dirmi che Ramon la picchia e spesso torna a casa ubriaco. Io ne ho
abbastanza di uomini così. Ne ho conosciuti troppi da quando è morto
papà”.
“Deve piacere a
lei, in fondo”.
“Sì, però lo
mantengo io”.
“Basta Juliana,
per favore. C’è il bambino che sente. Non vorrei che andasse a
riferire tutto”.
“Daglis non è
stupido. Sa che certe cose non si dicono. Vero, Daglis?”
“Io sto pensando
soltanto a questa stupida poesia. Non è che potrei andare a giocare
un po’ con la pelota? Finisco dopo…”.
“Va bene, vai. Ma
per cena voglio che tu l’abbia imparata. Intesi?”.
Lo accompagno con
lo sguardo. Daglis esce correndo per strada dove incontra il solito
gruppo di amici, ragazzi di tutte le età che improvvisano due
squadre di baseball in un campo delimitato dalla loro fantasia. Mia
madre passa in cucina dove sta bollendo un pentolone di riso e
fagioli. Nel forno c’è un pezzo di maiale ad arrostire.
“Friggerò un po’
di banane con le patate. Per il resto la cena è già pronta” mi dice
dall’altra stanza.
Io la sento
appena. Poi mi addormento sul divano.
La notte è stata
faticosa e devo recuperare le energie perdute.
|
|
Trovi alcuni libri di
Gordiano Lupi:
L'età d'oro,
Sangue tropicale e Il mistero di
Incrucijada in formato E - BOOK a questo indirizzo:
http://www.freebooks.it
C'è anche LETTERE DA LONTANO, il
primo libro (esaurito) di Gordiano Lupi, una raccolta di racconti
sulla solitudine
Trovi Il
giustiziere del Malecon e Fame
su
www.ebookclub.it |
 CULTURA
CUBANA
CULTURA
CUBANA

 IL GIUSTIZIERE DEL MALECON
IL GIUSTIZIERE DEL MALECON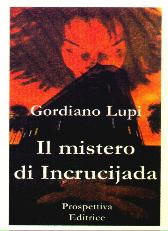 IL MISTERO DI INCRUCIJADA
IL MISTERO DI INCRUCIJADA